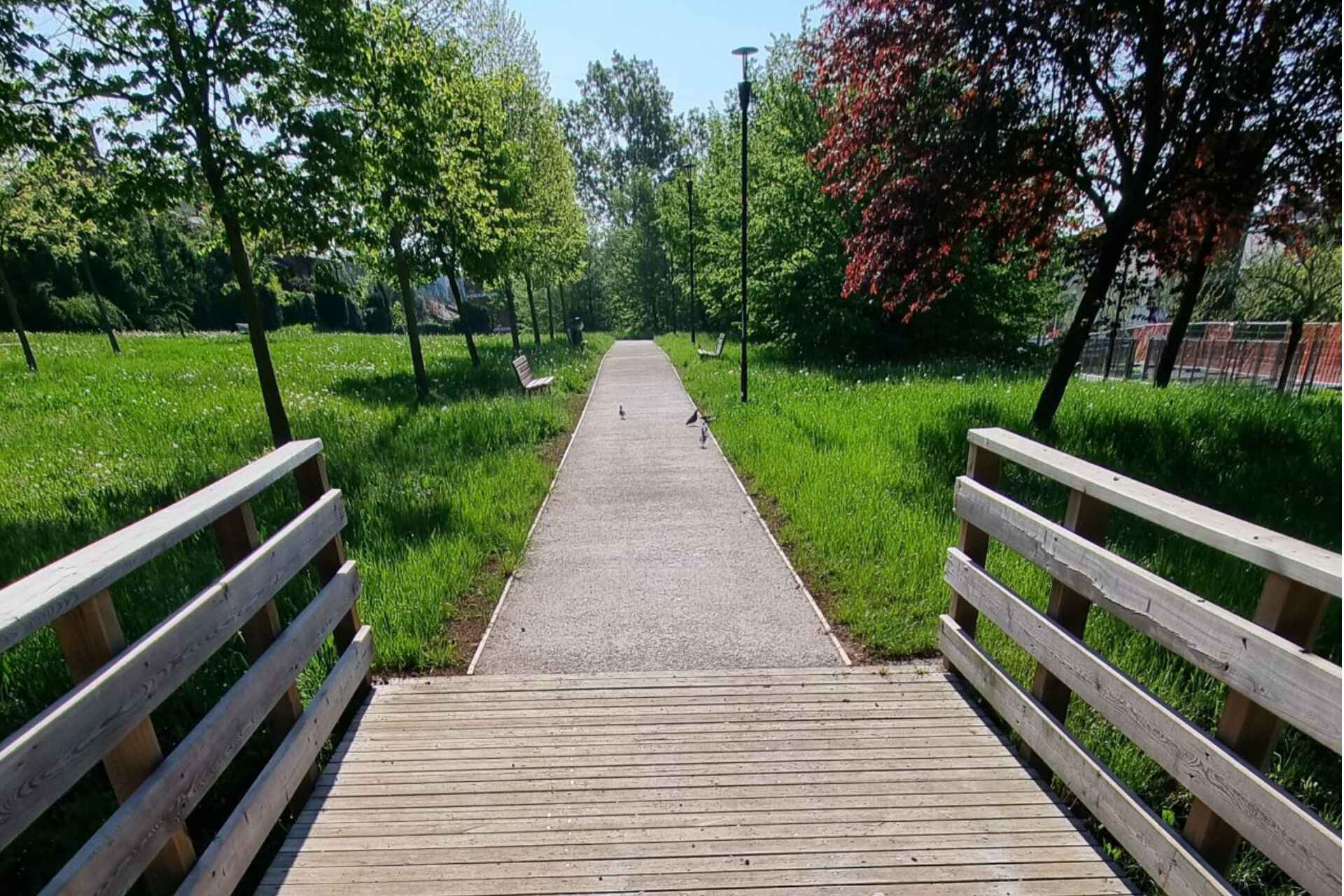La Visione di Andrea Cassone: AIAPP e il Futuro del Paesaggio Italiano
Architetto, educatore, e visionario del paesaggio, Andrea Cassone è oggi una delle voci più autorevoli nel campo della progettazione sostenibile e nella tutela del patrimonio naturale e culturale. Come Presidente di AIAPP, ci guida attraverso i valori fondanti dell’associazione, le sue iniziative, e le prospettive per le nuove generazioni di paesaggisti, in un dialogo che unisce tradizione, innovazione e responsabilità ambientale.
Contesto: L’Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio (AIAPP)
Fondata nel 1950 a Roma, AIAPP è l’Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, e rappresenta un punto di riferimento per tutti coloro che si dedicano alla progettazione e alla tutela del paesaggio in Italia. Membro fondatore di IFLA (International Federation of Landscape Architects), AIAPP è nata con l’obiettivo di valorizzare la professione del paesaggista, promuovendone la conoscenza e il ruolo strategico in ambiti urbanistici, culturali e ambientali.
L’associazione opera con un approccio multidisciplinare, coinvolgendo esperti di vari settori per affrontare le complesse sfide della progettazione paesaggistica moderna. Tra i suoi valori principali spiccano la tutela del patrimonio storico e ambientale, l’educazione alla sostenibilità e la promozione di soluzioni innovative che rispettino l’equilibrio ecologico. AIAPP sostiene che il paesaggio non sia solo un elemento estetico, ma un diritto collettivo e una componente essenziale della qualità della vita, come sancito dalla Convenzione Europea del Paesaggio (2001).
Attraverso eventi, progetti di formazione e iniziative di sensibilizzazione, AIAPP si impegna a trasmettere l’importanza del dialogo tra tradizione e innovazione. Il suo ruolo è cruciale per il futuro del territorio italiano, sia in termini di protezione dell’eredità culturale, sia per la creazione di spazi vivibili e inclusivi. Per i giovani professionisti, AIAPP rappresenta non solo un’opportunità di crescita e confronto, ma anche un’occasione per contribuire a una missione di grande impatto sociale e ambientale.

L’intervista.
Arch. Cassone, Lei è Presidente Nazionale di AIAPP. Quali sono i valori che la sua associazione promuove sul territorio italiano e con quali iniziative? Perché un giovane paesaggista dovrebbe iscriversi ad AIAPP, con quali prospettive?

L’Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio – AIAPP è una casa del paesaggio, se non “la” casa del paesaggio, in Italia.
Che cosa voglio dire definendola così?
Intendo dire che è il riferimento naturale per tutti coloro che si occupano di paesaggio, per lavoro, per studio e ricerca, per semplice interesse personale. È una casa che ha ormai quasi settantacinque anni; AIAPP è stata infatti fondata nel 1950 a Roma, alla Casina dell’Orologio di Villa Borghese.
I valori che l’associazione promuove dunque sono i valori di un sodalizio che promuove un lavoro, una professione – l’architetto del paesaggio, il paesaggista – la sua conoscenza, la sua formazione e la sua presenza sia nell’ambito del Paese cui si riferisce direttamente – l’Italia – sia, più in generale, negli ordinamenti sovranazionali cui essa appartiene.
AIAPP è infatti, fin dalla sua nascita, membro di IFLA, la International Federation of Landscape Architects, che ha contribuito a costituire, due anni prima di AIAPP, a Cambridge (UK) nel 1948, grazie a due dei suoi soci fondatori, Elena Luzzatto e Pietro Porcinai.
I valori di un’associazione di lavoro e professione sono innanzitutto la custodia e la trasmissione fedele dell’eredità ricevuta – conoscenza e pratica dell’architettura del paesaggio – sono poi la sua presentazione e il suo sviluppo per l’interesse generale della comunità d’appartenenza, vista l’importanza che il paesaggio ha per definizione (Convenzione di Firenze 2001) nella vita di tutti coloro che ne fanno parte e nell’equilibrio generale dell’ambiente che ci circonda.
Vi è anche – in Italia specialmente – un dovere/valore speciale: la tutela intelligente dell’immenso patrimonio ricevuto – storico, artistico, ambientale etc. – espressione di una tradizione che è stata, nel suo insieme, fondamentalmente paesaggio/paesaggi e che ancora oggi è un riferimento imprescindibile per chiunque si occupi, nel mondo, delle discipline dell’architettura del paesaggio e della corrispondente Landscape architecture.
Per tutte le ragioni che si possono desumere dalla presentazione dell’associazione – tutela dei valori di un lavoro, di una professione, fedeltà a una disciplina e cura della sua trasmissione, diffusione della conoscenza e affermazione di una professione che è anche e soprattutto moderna, dovere di tutela e valorizzazione dell’eredità ricevuta – oggi AIAPP credo possa rappresentare al meglio un riferimento, una casa.
Per i giovani professionisti naturalmente è anche un’opportunità di confronto e crescita professionale.
È poi importante sottolineare che, per sua stessa natura, il paesaggio richiede la propensione alla capacità di dialogo e coordinamento inter e multi-disciplinare. Oggi tale propensione, tale qualità costituisce senz’altro un valore aggiunto, professionale e civile al tempo stesso, disponibile per le nuove generazioni, per lo sviluppo e l’affermazione di una cultura sempre più responsabile del coinvolgimento collettivo nella custodia, nell’arricchimento della tradizione del paesaggio.
Se dovesse scegliere tre caposaldi che identificano maggiormente il suo modo di intendere il design del paesaggio, quali sceglierebbe e perché?
Tre parole chiave e guida della mia visione dei progetti paesaggisticamente consapevoli sono: comprensione, cura, regia.
Comprensione
La comprensione è la conoscenza che deriva dall’aver fatto esperienza dei principi e della teoria. Occorre comprensione per potersi avvicinare consapevolmente al paesaggio, poiché il paesaggio ha una dimensione concreta, talmente ricca e caleidoscopica, quasi inafferrabile a volte, da poter facilmente portare a scelte progettuali, basate su presupposti generali, contraddittorie e semplicistiche.
La comprensione chiede attenzione, tempo e pazienza, ma si traduce quasi sempre poi in scelta sicura e “vera”; la comprensione è infine autentica innovazione poiché quest’ultima, in termini paesaggistici, è bene sia vista innanzitutto come possibilità insita nel paesaggio stesso. Per individuarla, la pratica della comprensione è quindi indispensabile.
Cura
La cura è attenzione continua all’integrazione, alla compiutezza; si attua principalmente attraverso la comprensione, la riparazione, la correzione. Obiettivo finale della cura è il risanamento permanente, uno stato di equilibrio dinamico che, con riferimento all’ecologia, garantisca il massimo grado di benessere compatibile con le condizioni di un sistema ambientale.
Accingendosi a progettare, quindi, si dovrebbe sempre avere attenzione allo stato di fatto da cui si parte – si tratti di un giardino, di un parco, di una parte di città o di paesaggi più complessi – vedendolo nella sua qualità di sistema vivente, qualità che occorre “ascoltare”, comprendere e, all’occorrenza, spesso purtroppo, risanare.
In assenza di autentica cura ogni progetto purtroppo corre il rischio di assomigliare a un intervento di chirurgia plastica non necessario (interventi certamente da non escludere, ma da valutare attentamente in base a molte diverse considerazioni).
Regia
Il paesaggio rappresenta un grado di lettura, interpretazione e trasformazione dell’ambiente naturalmente sovraordinato, alle scienze del territorio, alla pianificazione ambientale, all’urbanistica, all’architettura, all’arte dei giardini etc.
La responsabilità dell’architetto del paesaggio nel suo impegno è importante: si ha a che fare con la percezione da parte delle comunità e dei singoli che ne fanno parte del proprio spazio e tempo, della scena, dei luoghi della vita.
È una responsabilità che chiede una virtù registica, virtù che consiste nell’esercitare l’onere dell’ultima parola, ma solo dopo avere ascoltato tutti e aver condotto l’ascolto in un clima di appartenenza a una visione, a un obiettivo minimo: la creazione di condizioni di benessere per tutti.
Intorno al tavolo di un paesaggista dovrebbero e dovranno potersi sedere sempre medici, biologi, geologi, naturalisti, agronomi e forestali, esperti in diritto, economisti, architetti etc.
Potrei a lungo dilungarmi sui temi legati alle tre parole guida che ho presentato, preferisco però fermarmi anche perché è giusto che ciascuno possa approfondirle a suo modo: sono tre pietruzze lasciate, al modo di Pollicino, sono una traccia o, per entrare in un campo molto vicino al paesaggio, nella sua consistenza tellurica, sono dadi da brodo che ciascuno potrà poi arricchire e sviluppare a suo modo.

Tra le sue attività c’è l’insegnamento scolastico. Quali sono gli aspetti legati al talento del singolo che vanno tutelati dal sistema scuola e con quali strumenti?
Il talento del singolo… è una domanda perfetta, grazie. Credo fermamente nelle qualità del singolo, nelle peculiarità dei singoli. Il singolo, però, può crescere e manifestarsi solo nel suo pieno conoscersi e il conoscersi del singolo può realizzarsi solo nel confronto con il gruppo, la comunità, il mondo, perché essi sono il suo naturale e immediato riflesso.
L’insegnamento perciò è per me teorico per tutti e pratico poi per ciascuno, in clima di laboratorio, di squadra.
In particolare, insegnando Ingegneria Habitat e Ambiente (IHA – Ingegneria rappresenta nel titolo tutte le professioni tecniche), è necessario che una parte dell’esperienza del corso si svolga in quel clima di regia cui ho accennato parlando delle mie parole chiave nella progettazione di paesaggio.
Concretamente: gli allievi seduti intorno a un medesimo grande tavolo imparano, progettando, il lavoro di squadra, dandosi del lei e costruendo progressivamente il loro contributo all’impegno di tutti, in termini di idee e di pratica. Al termine del corso a ciascuno potrà essere assegnata una sua modalità di regia, provvisoria e limitata, tuttavia importante.
È giusto infatti che ogni allievo si possa cimentare anche nel ruolo solitario per eccellenza del responsabile del gruppo, del regista. La formazione all’“essere”, alla qualità individuale, è prioritaria; strumenti tecnici e altro seguiranno e potranno essere impiegati al meglio una volta acquisita la comprensione della propria natura, delle proprie possibilità e la visione degli sviluppi infinitamente creativi che ognuno di noi ha in sé, dormienti.
Gli effetti del cambiamento climatico sul suolo sono sempre più determinanti nella vita delle persone in relazione al paesaggio che le ospita. Con quali idee e tecnologie perseguire l’obiettivo dell’equilibrio idrologico?
I cambiamenti ambientali – fra cui il climatico è oggi particolarmente di attualità – sono la naturale conseguenza di un pianeta che ha visto la sua popolazione più che raddoppiarsi nell’arco di due generazioni.
Difficile fare previsioni sia di carattere ottimistico che pessimistico – inclino per natura all’ottimismo, il catastrofismo di molti mi sembra parte integrante del problema e talvolta persino un comodo alibi – siamo comunque certamente chiamati già da ora all’attenzione, alla cura rivolte ad alcune delicate condizioni “base” per la qualità della vita e degli ecosistemi in cui la vita si organizza e articola.
Fra le condizioni base sicuramente c’è la qualità dell’acqua e del suo ciclo. Le precipitazioni meteoriche e i suoli, nel loro rapporto, sono un tema di capitale importanza.
Occorre favorire il drenaggio e l’assorbimento dell’acqua piovana nel maggior grado possibile (compatibilità) con l’ambiente in cui si opera. Occorre farlo con sempre maggior cura e articolazione di tipologia di intervento, sia per ciò che riguarda tutte le realizzazioni infrastrutturali (dai semplici percorsi come i sentieri, fino alle forme viarie d’utilizzo dello spazio più complesse etc.), sia per ciò che riguarda gli spazi dell’agricoltura e gli spazi naturali in senso ampio.
Le tecnologie possono essere molte, dal sempre migliore apporto dei vivai e delle coltivazioni fino all’uso di tecniche realmente bio-sostenibili (cioè attente agli effetti sulle condizioni di tutto il vivente e non solo legate a un paradigma tecnico-economico rapportato solo al ciclo energetico e di vita di materiali, elementi e tecniche).
Tornando alle parole chiave, occorre trovare soluzioni che siano legate a comprensione, cura e regia.
In primis, quindi, occorrerà usare sempre le risorse che madre natura ci fornisce – per esempio:
- Per le piante, le specie che meglio garantiscono resistenza e tenuta alle variazioni di apporto idrico;
- Per le infrastrutture, le terre che possono facilitare il drenaggio, anche in ambiente urbano;
- Per le abitazioni, i sistemi di raccolta dell’acqua piovana e l’adozione di normative che prescrivano l’impiego della cosiddetta terza rete (acque grigie) etc.
Molto, insomma, si può fare con ciò che già abbiamo, usandolo con intelligenza in forza della comprensione vera dei materiali, degli elementi e delle tecniche e abituandosi così a curare, riparare, risanare, in clima di regia, lo stato attuale in vista del benessere collettivo.

Quali sono gli aspetti tecnologici legati all’evoluzione dei materiali che maggiormente contribuiscono in progettazione allo sviluppo sostenibile del paesaggio e perché?
Collegandomi a quanto detto nella risposta alle domande precedenti, evidenzierei alcune necessità.
Premetto che vengo da una scuola che ha avuto molto a che vedere, anche direttamente, con la baubiologie, con la bioarchitettura etc.; sono perciò estremamente sensibile al tema dei materiali, degli elementi e delle tecniche, sotto l’aspetto della loro radice naturale, delle trasformazioni, del ciclo di vita e del consumo energetico complessivo (senza farne un super parametro, è certamente ancor oggi un dato della massima importanza).
Voglio dire, in sostanza, che senza cadere nel manicheismo di maniera (… i prodotti “di sintesi” sono male etc. … falso! Non c’è nulla di male in sé, a questo mondo; tutto dipende dalla trasformazione, dal contesto e dalla quantità etc. cui un materiale è stato sottoposto, intendendo con materiale ciò che viene prelevato dalla natura, con il minimo possibile di artificio), è tuttavia evidente che oggi sia sempre più necessario:
- Nella scelta di materiali ed elementi, orientarsi sempre su quelli disponibili localmente o in prossimità del luogo di progetto (fatte salve ovvie necessità di scelta differente per insufficienza di qualità funzionali etc.);
- Scegliere materiali, elementi e tecniche d’impiego diretto e non mediati da operazioni complesse di lavorazione/trasformazione: sono da privilegiare terra, argilla, inerti direttamente disponibili, calcari, pietre, legno etc. Se ciò può essere oggi piuttosto complicato nell’architettura (ciclo edilizio consolidato, e tuttavia qualcosa si sta muovendo anche nelle costruzioni), dovrebbe essere naturale nel paesaggio;
- Confrontarsi sempre con la storia di un luogo (comprensione), soprattutto in termini di valori percettivi e sensorialità (il paesaggio è definito in termini di percezione dalla Convenzione Europea, è estremamente importante tenerne sempre conto);
- Scegliere materiali ed elementi che possano essere sempre oggetto di interventi migliorativi: cioè materiali che possano essere integrati, modificati o perfezionati se ammalorati o per altri motivi senza che ciò debba significare la sostituzione o demolizione della tecnica realizzata. È il segreto dei segreti (e anche un’eredità della tradizione latina): demolire per età, malfunzionamento o per costi di manutenzione troppo elevati è sempre una sconfitta. I materiali, gli elementi e le tecniche migliori sono quelli che grazie alla cura (parola che sempre ritorna) potranno durare a lungo.